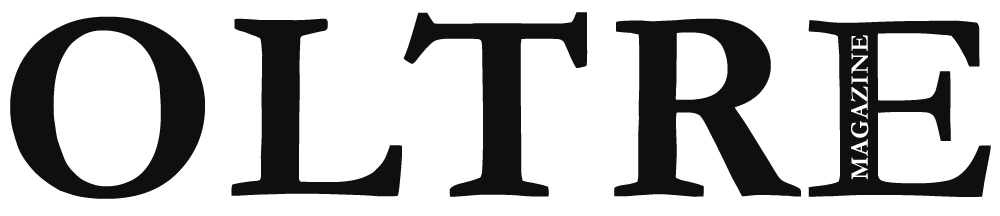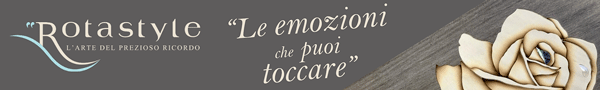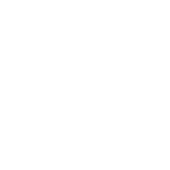Le "post mortem" cards"
Un ricordo che svanisce
Le fotografie post mortem nascono da una idea di Joseph Niépce e del figlio Isidore: sviluppatesi in epoca Vittoriana sono state in auge per oltre un secolo, cadendo in disuso attorno agli anni ‘40 del Novecento. 
Con l’invenzione della dagherrotipia, il primo procedimento per lo sviluppo di immagini fotografiche non riproducibili messo a punto dal francese Louis Jacques Mandé Daguerre, è stato possibile per la prima volta nella storia catturare un istante di vita, anche se, nel caso delle post mortem cards, dovremmo dire più propriamente “fissare la morte”. Questa grande invenzione venne presentata nel 1839 dallo scienziato François Arago presso l’Académie des Sciences et des Beaux Arts. Fino a quella data l’unico modo per tramandare la propria immagine ad altri era quello di farsi ritrarre in un dipinto, ma a causa degli elevati costi e del notevole impiego di tempo era una pratica riservata a pochi eletti (re, regine, papi, cardinali, politici, commercianti, scienziati).
Ogni epoca ha cercato di conservare il ricordo dei propri defunti arrivando a impiegare tecniche artistiche specifiche: con l’avvento del dagherrotipo e della fotografia anche la gente comune ha avuto la reale possibilità di posare insieme ai propri cari scomparsi; era nato il bisogno non solo di avere memoria dell’evento, ma anche di custodirla, rendendo la fotografia una sorta di moderno “memento mori”. Non bisogna commettere l’errore di pensare che fosse una pratica macabra o terribile: a quel tempo vi era una concezione della morte differente da quella odierna. Lo spirito del post mortem è stato adottato anche da noi nelle immagini poste sulle tombe o sui loculi, ma si tratta di istantanee precedenti il decesso, che ritraggono la persona ancora in vita.
Gli studi fotografici dell’epoca si organizzarono per assecondare le richieste dei dolenti, costruendo e talvolta inventando arredamenti e posizioni poi ritenute tipiche delle immagini post mortem. Era possibile eseguire gli scatti a casa del defunto o presso lo studio; molti professionisti arrivarono addirittura a firmare le fotografie o comunque a inserirvi il proprio nome a titolo di pubblicità. Le post mortem cards furono particolarmente in voga nell’epoca Vittoriana quando la mortalità infantile era molto elevata: non di rado erano l’unico ricordo che i genitori avrebbero serbato dei propri figli. Questo spiegherebbe perché i soggetti siano per lo più ritratti come se ancora fossero in vita, con gli occhi aperti o addirittura impegnati in piccole attività quotidiane. Non è raro trovare trucchi di scena e attrezzi atti a sorreggere i corpi senza vita.
Alcuni studi recenti tendono a dimostrare che l’usanza vada ricondotta a più antiche e radicate pratiche di tanatometamorfosi (trattamento delle spoglie). In questo caso essa rappresenterebbe una sorta di mummificazione visiva dove la sembianza di vita è resa necessaria per esprimere lo stato di salute dello spirito del defunto. Ma l’idea rimane la stessa: fotografare per ricordare, per fissare in eterno ciò che in realtà già non è più.
La successiva invenzione delle carte da visita, cioè delle foto ritratto che consentivano di stampare più copie da un unico negativo, permise che le immagini fossero inviate ai parenti, in ricordo dei defunti, solitamente accompagnate da una didascalia sul retro. L’iconografia del post mortem si adattava alle tendenze dell’ epoca variando a seconda degli anni e dei luoghi; i bambini, ad esempio, solitamente venivano fotografati con le manine giunte in quella che è chiamata “la posizione del dolce sonno”. È probabile che i corpi venissero imbalsamati con arsenico, sale, alcool e formaldeide nonché vestiti con i migliori abiti e fotografati, impressi in una sottile lanina di argento.

La prima ondata di post mortem cards, iniziata subito dopo il 1840, prevedeva immagini di volti con gli occhi chiusi o posizioni simil dormienti; sono rare quelle di corpi interi o di salme posizionate nelle bare. Il motivo è facilmente intuibile: la gente moriva nel proprio letto. Dopo gli anni ’50 del secolo decadente si tendeva a far apparire i cadaveri ancora vivi, ben vestiti e truccati: gli occhi sono dipinti sulle palpebre chiuse o direttamente sulla fotografia oppure, in alcuni casi, tenuti realmente aperti; anche le guancie e la bocca venivano colorate di rosa o di rosso per rendere meglio l’idea di una vita sana e reale, ma finta. I bambini erano messi a dormire nella propria culla o immortalati con i loro giochi preferiti; i neonati solitamente erano fotografati tra le braccia della propria madre. Gli adulti invece venivano posizionati seduti su sedie o su divanetti, vicino agli altri componenti della famiglia. L’idea di fotografie in cui insieme al cadavere si trova l’intero gruppo familiare era quella di proporre un ritratto collettivo, analogamente a quanto si sarebbe fatto quando ancora il defunto era in vita.
La fotografia del dolore è andata pian piano scomparendo, assumendo agli inizi del ‘900 un valore più sacro: i defunti erano immortalati direttamente nelle bare, ricoperti di fiori, e rendevano davvero l’idea del trapasso, senza artifizi per simulare e per trattenere la vita. Fino agli anni ’40 del 1900, in alcuni Paesi, questa pratica è stata utilizzata; oggi, quasi ovunque, viene considerata volgare e antiestetica. Non è semplice reperire testimonianze iconografiche del fenomeno: il tempo deteriora ogni immagine impressa su lastra d’argento, su pellicola o su carta stampata, la cui vita media possiamo ipotizzare in circa cinquant’anni. E anche le più recenti tecnologie non si rivelano di grande aiuto. Esistono tuttavia esempi di ottima conservazione che hanno permesso ai primi dagherrotipi di arrivare fino ai giorni nostri.
Le fotografie alla fine svaniranno, proprio come accadrà a tutti noi ...