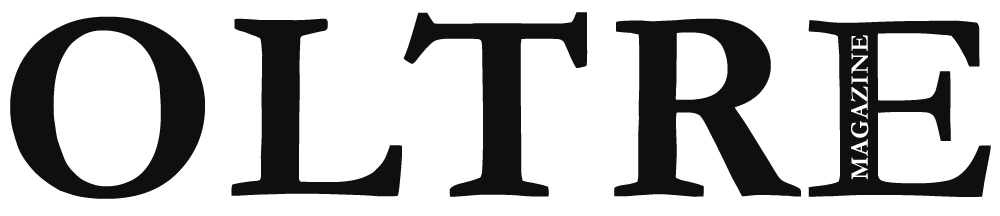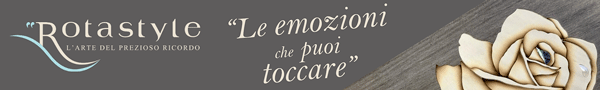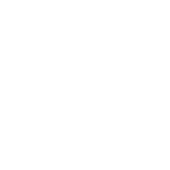A New Orleans dal 10 al 13 ottobre
NFDA 2010

Per una ragione o per l’altra non avevamo mai avuto, pur essendoci recati per motivi professionali o di svago parecchie decine di volte negli Stati Uniti, l’opportunità di soggiornare a New Orleans. Dobbiamo confessare che, chissà perché, la destinazione non ci era mai parsa estremamente interessante tanto più che il jazz non ci attirava oltre misura e non in ogni caso fino al punto di spingerci a visitare il luogo dove è nato. Sbagliavamo, eccome! Rimpiangere il tempo perduto non serve a nulla. Pensiamo piuttosto al futuro e ai prossimi viaggi in quella città che, più che una scoperta, ha rappresentato per noi un colpo di fulmine, lasciandoci in qualche modo storditi dal piacere, intenso, della rivelazione.
L’occasione ci è stata data dalla convention della NFDA (National Funeral Directors Association), la federazione funeraria americana che ogni anno organizza la propria “grande messa” in una località diversa. Così nel 2011 saremo tutti nella “windy city”, Chicago (la città ventosa tanto cara a chi, come noi, si è affacciato al mondo in quella Trieste battuta dalla “bora”), per ritrovare amici e conoscenti di ormai vecchia data. Quest’anno la scelta si è orientata sulla Louisiana ed in particolare sulla sua capitale economica visto che quella amministrativa è la vicina Baton Rouge. Accade spesso, negli “States”, che le capitali non corrispondano, per ragioni storiche, ai centri più importanti. Così quella dell’Illinois è Springfield (e non Chicago), quella della California è Sacramento (e non San Francisco o Los Angeles) e quella dello stato di New York è Albany (e non, come verrebbe spontaneo di pensare, la “Big Apple”). Potremmo continuare per una gran parte dei cinquanta stati dell’unione.
In realtà l’evento già nel 2005 avrebbe dovuto tenersi nella terra dei “bayous” (deformazione del francese “boyau”, budello), quei canali con acque poco profonde, stagnanti o di corrente debole che caratterizzano una parte di quello stato. L’uragano Katrina ci mise, alla fine del mese di agosto di quell’anno, lo zampino. Meglio sarebbe dire l’artiglio mortale visto il numero di vittime (ufficialmente 1.836 morti) che esso provocò obbligando molti altri abitanti ad emigrare altrove visto che in tale catastrofe avevano perduto tutto, a cominciare dal tetto. Talché oggi nella città vive poco più della metà delle 450.000 persone che essa contava prima del ciclone. Tutti ricordano le tragiche immagini di quei giorni quando ai danni prodotti dalla forza della natura, contro la quale è improbo in certi casi combattere, si sono aggiunti quelli cagionati dall’incuria degli uomini. Soprattutto di quelli che durante il boom edilizio del dopoguerra hanno edificato a spron battuto incuranti dell’ambiente quando non addirittura assumendo, da irresponsabili, decisioni aberranti come quella di costruire canali a partire dalle rive del lago Pontchartrain. Quegli stessi canali che, a causa delle piene e dei riflussi provocati in essi dai venti e dalle acque dalla tempesta, hanno portato al cedimento delle dighe, già inadeguate secondo molti esperti, che si supponeva potessero proteggere la città in casi estremi. La natura, dovremmo ormai averlo imparato, prima o dopo presenta il conto! Salato per tutti a causa di chi, nella sua cieca e criminale corsa al profitto, colpevolmente dimentica che certi equilibri non vanno modificati. Come è accaduto del resto quest’estate, ancora in Louisiana, con la tragedia della fuga di petrolio nel golfo del Messico. Di tale sventatezza umana, conseguenza della rapacità che spesso ci anima, abbiamo avuto un ultimo e di certo non definitivo esempio recentissimamente quando si pensi alla vicenda dei minatori cileni risoltasi fortunatamente con il salvataggio di tutti quei poveri cristi. Queste tristi vicende non fanno che confermare, con il loro implacabile ripetersi, la fondatezza di un vecchio proverbio serbo che recita: “L’uomo è il più perfetto errore della natura”. Sottoscriviamo al cento per cento!
Una delle poche, se non l’unica, conseguenza positiva dell’hurricane è stata la diminuzione della criminalità in quello che era stato sino ad allora uno dei luoghi più pericolosi del Nord America. Infatti quasi tutti gli sfollati erano originari delle zone povere della città. I residenti dei quartieri ricchi o turistici se la son cavata con danni ai tetti a causa del vento, ma le loro case, ben piantate in terra, non sono state trascinate via dalle acque anche perché esse si ergono in zone situate al di sopra del livello del mare, a differenza di quelle in legno dei sobborghi diseredati. Non occorre essere sociologi di chiara fama per comprendere che i focolai di criminalità allignano maggiormente, e fatalmente, là dove le tensioni, dovute all’indigenza, sono esasperate e spesso portate alle estreme conseguenze. Katrina ha fatto disperdere un po’ dappertutto in America quelle popolazioni contribuendo, nello stesso tempo, ad eliminare la delinquenza che le caratterizzava e che faceva di New Orleans un vero e proprio problema nazionale sul piano della sicurezza. Un po’ come la New York ante-Giuliani o la Detroit del boom motoristico repentinamente svuotatasi dopo la crisi dell’automobile con conseguenze spettacolari sul mercato immobiliare i cui prezzi sono diminuiti, in certi casi, fin dell’80%!
In quel tremendo 2005 la NFDA si trovò nella situazione di dover gestire l’urgenza trovando un’altra sede. Provvidenzialmente Philadelphia, che ospita nell’Indipendence Hall la venerata campana che con i suoi battiti sanzionò l’indipendenza degli Stati Uniti, si rese disponibile. Ora il debito con “Big Easy”, nomignolo della città che fa riferimento alla vita spensierata e rilassata dei propri cittadini, in primis i numerosissimi musicisti jazz, è saldato. È tornato il momento, come continuano a dire colà in francese, di “laisser le bon temps rouler” (far scorrere il buon tempo presente), precetto edonistico che potremmo considerare la versione louisianese del “chi vuol esser lieto sia…” di Lorenzo de’ Medici o del vecchio “carpe diem” di oraziana memoria. Il concetto è lo stesso: “del doman non v’è certezza”. La vita ce lo conferma giorno dopo giorno.
Nella New Orleans dell’inizio del secolo scorso prosperava, fino al 1917 quando esso fu chiuso e quasi totalmente demolito per decisione dell’ammiragliato, Storyville, un quartiere situato al nord del “French quarter” e contiguo al cimitero di Saint Louis. Esso era riservato agli stabilimenti specializzati nel fornire giusto ristoro ai cultori degli amplessi tariffati. Proprio qui è nato il jazz. Tutti coloro che, dopo il declino delle “plantations”, arrivavano in città senza lavoro, e conseguentemente senza il becco di un quattrino in tasca, si ritrovavano all’ombra degli alberi della vicina Congo Square (oggi Armstrong Square) per cantare (canta che ti passa!) e per suonare soprattutto le percussioni rifacentisi alle origini ancestrali africane. In seguito al divieto di usare tali strumenti altri ne presero il posto e si crearono complessini di suonatori da strada che spesso accompagnavano, nelle loro divise rutilanti, i fedeli per il loro ultimo viaggio. Che, secondo la tradizione, se è austero nella prima parte (l’andata al cimitero e la sepoltura), lo è molto meno alla fine quando, sistemato per l’eternità il caro estinto, tutti ritornano in città tra musiche, canti, risate e buonumore epidemico e contagioso. Finendo poi per disseminarsi nei diversi locali per brindare alla gloria e alla memoria del defunto. Tutto molto bello e “funny” (spassoso), ma bisognava anche mangiare. Per questo provvidenziale fu l’idea dei tenutari dei sopracitati luoghi di perdizione, di organizzarli su due livelli in modo da proporre agli avventori un rilassamento spirituale in chiave (è il caso di dirlo) musicale propedeutico a quello, molto meno etereo, del corpo. Mentre di quest’ultimo si occupavano, con talenti diversificati ed apprezzati, le sacerdotesse di Venere del piano di sopra, del primo si incaricavano, in modo altrettanto talentuoso ma di tutt’altro registro, le “band” formate in grandissima maggioranza da uomini di colore. Tra di essi si distingueva un certo Louis Armstrong che per qualche benvenuto dollaro si esibiva ogni sera, prima di essere scoperto da un impresario di Chicago (che diventerà la capitale del jazz, successivamente trasferitasi a New York e poi ancora a Londra, Parigi ed Amburgo), al pianoterra dell’Anderson’s Annex. Al piano (il primo, e non quello forte) altra musica signori!, eseguita, con tutte le variazioni sul tema, dalle virtuose della “jambe en l’air”. La traduzione è superflua.
Uno scorcio suggestivo di tali ambienti ci viene dal grande regista francese Louis Malle nel suo film del 1978 “La Petite” (“Pretty Baby” in inglese da una canzone di Tony Jackson), con Brooke Shields nella parte di Violet girato per l’appunto al 1.208 di Bienville Street in uno dei tre “centri di rilassamento” ancor oggi in piedi pur non essendo più utilizzati per la destinazione iniziale. Segnaleremo per inciso che i tre minuti di scena in cui l’avvenente attrice, allora dodicenne (!), girava nuda come la fece mamma furono colpiti dalle folgori della corrucciata censura statunitense, anche se oggi è possibile visionare la versione integrale su dvd facilmente reperibili sul mercato legale. Tornando ad Armstrong (il leggendario “Satchmo” che ritroviamo, redivivo, in una statua che domina la sala arrivi dell’aeroporto cittadino che porta, ovviamente, il suo nome) egli fu rapidamente incoronato, nel 1925, re dei musicisti succedendo così a Joe Oliver che aveva preso lo scettro dal cornettista Buddy Bolden. Era il jazz delle origini, quello tradizionale che vive ancor oggi in certi locali creati mezzo secolo fa da chi non voleva che tale forma musicale scomparisse. È così che nel 1961 Alan e Sandra Jaffe fondarono la “Preservation Hall” dove viene eseguito ogni sera il jazz nella sua versione tradizionale. Il caso, che talvolta le cose le fa per bene, ha voluto che ci capitassimo mentre era in programma un concerto della Preservation Hall Jazz Band, una sorta di “orchestra stabile” del luogo, di cui fa parte, alla tuba (in questo caso tra i vari tipi di tuba, o filicorno, un susafono) Benjamin Jaffe, figlio dalla criniera leonina dei fondatori. Si esibisce normalmente il lunedì, il mercoledì e il sabato. Bene ce ne incolse. Per la modica somma di dodici dollari potemmo accedere ad una stanza, un po’ decrepita, di una capienza, al massimo, di una sessantina di persone di cui molte sedute a terra su cuscini di fortuna a mezzo metro dai musicisti. Ed approfittare così di tre quarti d’ora (tanto dura il concerto) di pura beatitudine in piena comunione, nel significato più compiuto del termine, con gli artisti, molti dei quali, come il settantottenne clarinettista Charlie Gabriel, sono gli eredi di diverse generazioni di jazzmen. Nel caso di Gabriel, che ha suonato anche con Aretha Franklin (!), siamo alla quarta. In quei momenti privilegiati si viaggia, trascinati dai musicisti, in un altro mondo dalla dimensione unicamente spirituale dove le sensazioni fisiche, anche quelle sgradevoli, miracolosamente spariscono. Una sola volta (se ne era, credo, parlato in un articolo precedente) avevamo provato la stessa sensazione di venire liberati dal calore ambientale. Doveva essere più di quarant’anni fa al “Verdi” di Trieste in occasione di un concerto dato dal sommo, e lunatico, Arturo Benedetti Michelangeli. Le prime note (si trattava di Chopin) che uscirono dal suo piano ci affrancarono, allora, dall’insopportabile caldo umido di quell’estate giuliana sollevandoci, quasi “per incantamento” come direbbe il Dante delle “Rime”, in un cielo azzurro dove ci sembrava di essere sensualmente accarrezzati da un fresco venticello. Ebbene lo stesso ci è accaduto qualche giorno fa al 726 della St. Peter Street (appena svoltato l’angolo della Bourbon St.) dove abbiamo sperimentato la stessa, intensa e oseremmo dire catartica, emozione. Da piangere, quasi. Eppure dovevano esserci, fuori, 27-28 gradi alle dieci di sera. Non c’è due senza tre, dicono. Fra altri quarant’anni sarebbe troppo tardi. La speranza è l’ultima a morire.

Ritornati in strada ci si ritrova immersi nel mondo di sempre con l’abbondanza di bar e di turisti (ma ci sono anche molti abitanti locali) che approfittano largamente degli innumerevoli locali dove le bibite scorrono a fiotti. L’ironia della sorte vuole che il centro di tale quartiere porti, in onore della famiglia (dei Borboni) di Orléans, il nome di Bourbon Street, anche se oggi il nome evocherebbe più che le altezze reali quelle delle botti di quercia impilate dove maturano i diversi tipi di “bourbon”, la versione yankee, e alquanto differente, del whisky scozzese. A ciò preferiamo un cocktail dal nome, mai tanto ben imbroccato viste le circostanze, di “Hurricane”, uragano. Il tempio di tale pozione è “Pat o’ Briens”, a due passi dalla “Preservation Hall”. Per la modica somma di otto dollari (in bicchiere di plastica da mezzo litro; per quello di vetro si pagano tre dollari in più, ma ci si può tenere il bicchiere souvenir) ci si rifornisce di un beveraggio rinfrescante a base di succo di frutta mescolato a diverse varietà di rum. Pozione ad alto potenziale inebriante, soprattutto dopo il terzo, quarto bicchierone che è il minimo che una persona di sana e robusta costituzione possa e debba trangugiare. Durante tutta la notte, per 365 giorni all’anno, la gente deambula allegra e imbibita di ogni sorta di liquido. È quindi abbastanza facile comprendere come il diffuso puritanesimo americano (più apparente, lo ripetiamo, che reale; tant’è che esiste quella contea dove una legge locale prevede pene severe per coloro che hanno rapporti sessuali con i porcospini!) abbia sempre cosiderato la festaiola e godereccia città come una novella Gomorra da bollare “ad aeternum” di un sigillo sulfureo (lo zolfo essendo l’elemento del diavolo). Senza parlare della vezzosa usanza di lanciare, dall’alto dei balconi e con il bicchiere in mano soprattutto durante le festività del “Mardi Gras”, delle collanine policrome per indurre le pulzelle a mettersele al collo dopo aver, in cambio, scoperto i seni mano a mano che le suddette collanine piovono nelle loro mani. O, peggio ancora, del voodoo, sorta di sincretismo religioso in cui la tradizione di magia della diaspora africana, soprattutto del Dahomey (oggi Benin), si mescola con il cattolicesimo e con la cultura di lingua francese della Louisiana del Sud come conseguenza del commercio degli schiavi. Noteremo, a titolo di curiosità, che la tomba, stupefacente, della grande sacerdotessa voodoo Marie Laveau si trova nel cimitero di St. Louis, quasi all’ingresso, vicina a quella borghese e tradizionale di Ernest N. Morial, l’amato primo sindaco di colore della città che ha dato il nome al centro espositivo dove si è svolta la NFDA. Suo figlio, Marc H. Morial, è stato egualmente sindaco dal 1994 al 2002.
La connotazione negativa affibbiata loro dai compatrioti non turba oltre misura i felici new-orleaners (?) che continuano, magari con passo incerto, per la loro strada e con le loro ben radicate abitudini menando, spensieratamente, quella che alcuni hanno definito come la vita di Giovinazzo (qui non si parla del comune pugliese, ma di un personaggio mitico della tradizione goliardica) il quale, come ben noto, “mangiava, beveva e non faceva un c….”.
Ciò detto, non è che la città si limiti al quartiere “francese” dove vissero, da dirimpettai in St. Peter Street, Tennessee Williams e William Faulkner nonché, in Royal Street, la cantante Adelina Patti. Quartiere che, sia detto “en passant”, più che francese è spagnolo, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto esterno delle case caratterizzate da balconi, spesso su più livelli, riccamente decorati con griglie in ferro finemente lavorato e rapportabili più alla tradizione artigianale spagnola che a quella francese.
Infatti, senza dilungarci sulla storia alquanto complessa della Nouvelle Orléans, ricorderemo che essa fu fondata nel 1718 dal canadese Jean-Baptiste Le Moyne Sieur de Bienville dopo che i francesi, discesi lungo il fiume Mississippi e provenienti dal nord attraverso i Grandi Laghi, si erano attribuiti un territorio gigantesco che andava dal Canada fino al golfo del Messico. Qui si ritrovarono genti di ogni provenienza (fuoriusciti europei, pirati, schiavi affrancati, indiani autoctoni e mercenarie del sesso; in pochi anni giunsero dalla Francia 1.600 donne di cui 160 prostitute) sotto la tutela bonaria del duca d’Orléans, reggente di Francia, fino a che la città passò sotto la dominazione spagnola diventando Nueva Orleans (dal 1762 al 1803). Del resto tutte le strade del “French quarter” portano ancor oggi targhe che indicano il loro nome all’epoca ispanica. Nel 1803 gli iberici restituiscono la città alla Francia, ma un anno dopo Napoleone la vende agli Stati Uniti non avendo i mezzi per amministrarla e per difenderla militarmente. Approffittando, tant’è, dell’occasione di andare contro gli interessi del nemico storico, l’Inghilterra. La città diventa rapidamente il porto più importante del Nord America e lo rimarrà per molti anni non solo per il traffico mercantile, ma anche per quello militare. Da lì partirono infatti i contingenti di quelli che furono spediti, secondo la strombazzante retorica ufficiale, per sacrificare nel corso dei due conflitti mondiali la propria vita per la libertà dei nostri paesi europei, ma anche per garantire la futura disponibilità di buoni mercati dove far fare business e far realizzare profitti agli industriali statunitensi. Ciò spiega, tra l’altro, l’intervento dell’ammiragliato nello smantellamento di Storyville dove i marinai e gli altri soldati dei differenti corpi andavano ad incanagliarsi, creando turbolenze nel settore, non appena ne avevano il tempo. Siamo al massimo: far casino nei casini!
In tale effervescenza anche gli italiani ebbero la loro parte. Una comunità di una certa importanza vi si stabilì, come testimoniato da un mausoleo del cimitero di St. Louis offerto dalla loggia massonica “Dante n. 174” e costruito in Italia prima di essere colà trasferito. Un personaggio di rilievo è Cosimo Matassa (che supponiamo ancora in vita), un italo-americano nato nel 1926 a New Orleans e proprietario di quello che è oggi un sito protetto (sede, attualmente, di una lavanderia) in Rampart Street (di fronte alla Louis Armstrong Square) e dove operò il Cosimo Recording Studio in cui registrarono i loro brani cantanti del calibro di Fats Domino, Little Richard, Ray Charles, Lee Dorsey, Dr. John, Siley Lewis, Bobby Mitchell, Tommy Ridgley, The Spiders, sviluppando il cosiddetto “New Orleans Sound”. Infatti, se è vero che la città è nota soprattutto per il jazz, è altrettanto vero che essa coltiva ogni tipo di musica: rock, brass band, funk, cajun music, zydeco, blues… Molti luoghi hanno conservato l’aspetto originale (decorazioni, mobilio, lampadari, ...) per cui ci si ritrova piacevolmente immersi in un viaggio a ritroso nel tempo e in un ambiente anni ’20 o ’30. Per i nostalgici, quali ad una certa età inevitabilmente si diventa, è un modo di rivivere epoche più vicine alla propria giovinezza.
Altri quartieri sono degni di rilievo. Tra di essi il faubourg (sobborgo) Marigny, contiguo al French quarter (conosciuto anche con il nome di “Vieux Carré”), dove dopo Katrina si sono stabiliti giovani artisti e dove fioriscono locali tra i quali si distingue il “Check Point Charlie”, aperto 24 ore su 24. E poi, all’ovest, il Garden District che ospita sontuose residenze borghesi, attorno al cimitero Lafayette (che purtroppo chiude alle 14.30). Esse evocano il tempo delle grandi dinastie di commercianti che volentieri immaginiamo adagiati, di bianco vestiti, nelle confortevoli poltrone di vimini delle proprie verande mentre, rinfrescati dal vento provocato dalle enormi pale dei ventilatori appesi ai soprastanti soffitti, discutono, un bicchiere in mano, di affari (cotone, zucchero, frutta esotica) milionari. Un po’ “Via col vento”, insomma. Dicono che nel quartiere abbia comperato da poco una “mansion” anche Brad Pitt. Tanto lui ne compera dappertutto!
Tra queste due zone si estende il Central Business District, cuore dell’attività economica dove si trovano, tra l’altro, il Morial Convention Center sede della NFDA nonché, verso nord, il più grande stadio coperto del mondo, il Superdome, capace di ospitare 90.000 spettatori e sede della locale squadra di football americano, quei “Saints” dai colori nero ed oro che hanno per la prima volta, l’8 febbraio 2010, conquistato il “Superbowl” battendo in finale proprio sul terreno di casa (scelto quest’anno per ospitare l’incontro “clou” della stagione) i favoriti “Colts” di Indianapolis. Ancor oggi tutta la città è ricoperta di bandiere e striscioni inneggianti ai campioni in carica. Che peraltro hanno iniziato la nuova stagione un po’ meno bene che lo scorso anno.
La parte sud del Business District è il Warehouse/Arts District. In esso, situato ovviamente lungo le rive del placido ed ampio Mississippi, c’è il centro espositivo mentre molti degli antichi magazzini sono stati trasformati per diventare stupende gallerie d’arte moderna o d’antiquariato nonché ristoranti di ogni genere e prezzo. Si va dalla cucina internazionale a quelle etniche (forte presenza ispano-americana soprattutto dopo la forte progressione di tale comunità nel periodo post-Katrina) a quella locale creola, o “cajun” (pronunciare “kègiun”). Il nome “cajun” deriva dagli abitanti dell’Acadia, terra corrispondente a quella che oggi è la provincia canadese della Nova Scotia. Lì vivevano popolazioni francesi che gli inglesi, una volta preso il potere, si affrettarono a far sloggiare anche con sistemi violenti. Molti di costoro si rifugiarono nelle vicine terre del Maine. Come ad esempio sull’isola di Mount Desert, di cui conserviamo un ricordo commosso per la bellezza selvaggia del paesaggio, e dove visse, scrivendo, Marguerite Yourcenar (sì, quella delle “Memorie di Adriano”), nata a Bruxelles come Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Cleenewerk de Crayencour e prima donna ad essere innalzata, nel 1980, agli onori dell’Académie Française.
Altri, più avventurosi, si spinsero oltre approdando con i loro battelli fin sulle coste della Louisiana e mescolandosi, poveri con i poveri, alle popolazioni di colore locali. Gli “Acadians” o “Acadiens” diventano progressivamente “cadians”, “cadjans” e, per ulteriore corruzione, “cajuns”. Da tale connubio nasce una cucina originale, la “cajun” per l’appunto, caratterizzata dall’abbondanza di prodotti marini e fluviali (gamberi, granchi, alligatori!) e dall’uso di spezie tra le quali una posizione privilegiata è occupata dal “chilli pepper”, il nostro peperoncino. Tutti sanno che proprio da quelle parti prospera, nella zona di “New Iberia”, la varietà Tabasco dal piccolo frutto da cui si estrae l’omonima salsa (oltre a tante altre dal nome diverso). Tuttavia nel corso di questo viaggio abbiamo avuto il piacere di conoscere un nuovo “brand”, più precisamente la “Dave’s Insanity”, che per il momento rimane il più potente a noi noto tra quelli prodotti su scala industriale.
Non ne conosciamo la forza determinata secondo la scala Scoville (un farmacista, Wilbur Scoville, che su base empirica stabilì nel 1912 un criterio per misurare la piccantezza della preziosa pianta). Possiamo tuttavia assicurare i cultori che si tratta di qualcosa di potente anche se manca, come quasi dappertutto, l’aroma inconfondibile dei peperoncini del sud dell’Italia e in particolare di quelli calabresi. A tale cucina sono riconducibili anche le due specialità “popolari” locali, la “Muffuletta” (o Muffaletta o Muffoletta) ed il “Po-Boy”. La prima trae il suo nome da un paninone, a base di ingredienti italici - salame, prosciutto, mortadella, formaggio, il tutto ricoperto da una salsa di capperi, olive e sottaceti - che gli immigrati siciliani (all’epoca tutti gli italiani erano considerati siciliani) sarebbero stati usi preparare per sfamarsi. Unico inconveniente: in Sicilia di tale pietanza non s’è mai sentito parlare. Così nascono i miti e le leggende. Il luogo di nascita sarebbe, sempre secondo la leggenda, la Central Grocery dove, richiesto del perché anziché preparare muffulette con un solo componente preferissero metterci dentro di tutto e di più, un personaggio aquilino, ossuto e, per dirla francamente, assai poco appetitoso, probabilmente il titolare, ci rispose pontificando e guardandoci come si trovasse di fronte ad un tarato: “The more the ingredients, the more the tastes” (più ingredienti, più sapori). Ci sarebbe venuto da consigliargli di metterci, già che c’eravamo, anche un po’ di succo di rabarbaro e, perché no?, un decotto di assa foetida. Oppure di proporre, per accompagnare la sua accozzaglia di “tastes”, un buon calice composto da una mescolanza di vini bianchi, rossi e magari anche un po’ di rosati tunisini, cileni, spagnoli, italiani e francesi in modo da fare il giro del mondo, dilettandosi di tutti i sapori, in un solo bicchiere. Quando si dice la co……ggine fatta persona! Con l’arroganza, in più, del nuovo ricco a-culturato (caratteristica, spiace dirlo ma quando ci vuole ci vuole, frequente in certi italo-americani sempre più americani e meno italiani, anche se pure da noi quanto a sciatteria, arroganza e maleducazione non è che si scherzi… basta vedere come guida la grande maggioranza dei nostri, manifestamente frustrati e zotici, compatrioti). Su tale affermazione tanto perentoria quanto imbecille abbiamo fatto un dietro front da cadetto dell’Accademia di Modena prendendo direttamente la direzione della porta.
Exit dunque la muffuletta. Arriva il “Po-Boy”. Si tratta di un “povero ragazzo” (poor boy) ed è un panino che all’origine veniva fatto con i resti (“debris”, parola francese usata ancor oggi in Louisiana e che significa “frantumi”, “avanzi”) che cadevano dallo spiedo dove si preparavano gli arrosti. Il personale dei ristoranti più generosi offriva tale pietanza ai poveri, famelici, ragazzi che stavano fuori dal ristorante e che così potevano per un po’ ritornare a sorridere. Che cosa c’è di più bello del sorriso di un ragazzo riconoscente e che, magari per un solo attimo, si sente amato? È tanto difficile trovare il tempo per pensare, e soprattutto agire!, per aiutare tangibilmente quei milioni di creature che in tutto il mondo, ma soprattutto in Africa, rischiano la vita per mancanza di cibo? Ogni persona di buona volontà, e speriamo che ce ne siano tante tra i lettori, saprà sbrigarsela per trovare a chi e dove dare il proprio contributo.
Il tempio del “Po-Boy” è oggi, non ci piove sopra, “Mother’s” dove per dieci dollari ci si può, sin dal lontano 1938, gradevolmente rifocillare (qualche centesimo in più per chi vuole i “debris” che da poco pregiati avanzi sono diventati - secondo una regola dei nostri giorni che vale anche, ad esempio, per la polenta - condimento ricercato). Il luogo è oggi proprietà degli amabili fratelli Amato che onorano il cognome che portano e che sono, loro sì, di origine siciliana. Esso si trova in Poydras Street al termine della quale (lato fiume) basta svoltare a destra per trovarsi dopo poche centinaia di metri all’ingresso del “Morial Convention Center”. Centro, come sempre negli USA, estremamente funzionale dove i congressisti potevano, oltre che partecipare, numerosi come d’abitudine, alle più svariate conferenze di aggiornamento e formazione, recarsi per visitare l’esposizione di prodotti indirizzati alla loro professione. Per ciò che riguarda questi ultimi diciamo subito che non abbiamo notato novità rivoluzionarie. Indubbiamente si nota uno sforzo di ricerca per differenziare, sulla base di criteri estetici e funzionali, il proprio prodotto, ma l’unica vera novità rimane quella dell’idrolisi alcalina, e cioè del trattamento dissolutivo del corpo in una soluzione acquosa a pH basico a condizioni ben definite di temperatura e di pressione. Quest’anno abbiamo visto un altro produttore di tale cisterna oltre a quello dell’anno passato. Del resto l’importante gruppo Matthews, di cui fa parte anche la Gem, assicura la distribuzione di uno dei due produttori negli USA. L’equivoco nasce dal fatto che impropriamente tale tecnologia viene definita come “bio-cremation”. Abbiamo avuto il nostro ben da fare per spiegare al presidente di una delle società che il termine “cremazione” è assolutamente improprio nella misura in cui esso è indissociabile dal fatto di “bruciare”. Del resto l’etimologia (ma questo l’abbiamo verificato una volta rientrati a casa) è chiara ed univoca, il termine trovando la sua origine nella radice “kar” (concetto di bruciare) del sanscrito che, dopo metatesi della “r”, diventa “kra” con tutte le derivazioni del caso. Comunque sia è facile prevedere che il sistema, per quanto funzionante, troverà un’opposizione compatta da parte di un sacco e mezzo di produttori di articoli funerari per ragioni ben evidenti a tutti. Tale prodotto vuole definirsi come cremazione probabilmente perchè tale pratica è in crescita costante in tutti i paesi del mondo. Tutti i produttori più importanti erano presenti, compresi due leader europei: l’olandese Facultatieve Technologies e l’italiana Gem. Attorno alla cremazione ruotano molti prodotti, ma tra di essi il più importante è l’urna. Ancora una volta la produzione nazionale si è distinta con la ABC Forever di Prato che avevamo già visto qualche mese fa a Bologna a Tanexpo e che proponeva, con Luigi Catalano e Chiara Nunziante, urne in acciaio plasmato in forme originali ed accattivanti.
Altro italiano, un “newcomer” nel mondo funerario, Luigi Boschin, un nostro corregionale della bella e quieta Gorizia. Attivo fuori d’Italia da moltissimi anni egli, assecondato dal figlio Luca, ha creato un’azienda svizzera, la SwissDnaBank, che raccoglie il dna del defunto per depositarlo, a disposizione delle generazioni future, in forzieri ricavati nelle gallerie scavate, per uso militare, nelle montagne della vicina Confederazione e cedute dall’amministrazione elvetica a chi ne prevede una nuova destinazione. Non potremmo chiudere questa rassegna di espositori europei senza menzionare l’olandese Facultatieve Technologies, col suo vicepresidente Patrick De Meyer sulla breccia, nonché l’inglese AARDBalm, con Richard Holdsworth a presentare i fluidi da tanatoprassi senza formaldeide. Per la prima volta si è presentato alla NFDA anche il titolare della Lutece, Zouhair Hertelli, azienda specializzata nei trasporti internazionali con uffici a Parigi e in Tunisia. Tra i visitatori operanti nella stessa attività abbiamo incontrato, con lo stesso immutato piacere, Piotr Godleswki (colui che ha assicurato il rientro in Polonia di tutte le vittime della catastrofe aerea di Smolensk dove perse la vita il presidente polacco) accompagnato dal suo partner statunitense Scott Nimmo con aziende nel New Jersey, in Florida e a New York nel West Side in quella parte, la Hell’s Kitchen (la cucina del diavolo), diventata famosa (in un giardinetto c’è una targa commemorativa) per le guerre di bande evocate in West Side Story e dove per la prima volta, nel 2000, avevamo incontrato l’amico Nimmo. Che oltre ad essere eccellente imprenditore è anche, ammettiamo la nostra invidia, eccellente con una mazza da golf in mano. Crediamo che se non è “scratch” (cioè con handicap zero) poco ci manca. Altrimenti non avrebbe potuto giocare sul percorso del Royal and Ancient Golf Club di St. Andrews in Scozia, mecca di ogni golfer e culla di quello sport che ancor oggi rappresenta la massima autorità per tutto ciò che riguarda le leggi ed i regolamenti che presiedono a quel nobile gioco dei pastori scozzesi. Che adesso sta propagandosi, a livello mediatico, anche in Italia grazie ai fratelli Molinari protagonisti della recente Ryder Cup, senza dimenticare l’importantissimo contributo del Costantino Rocca di qualche anno fa. Nel Global Village, voluto da Deborah Andres, la sempre attivissima responsabile internazionale della NFDA, c’erano, come d’abitudine, la FIAT-IFTA con Dirk e Lia Van Vuure assieme al solerte Gerard Knap, la boliviana Teresa Saavedra, presidentessa dell’Alpar e futura presidentessa della stessa FIAT-IFTA, nonché gli esponenti della federazione canadese. Ed ancora David Hyde che presentava l’ormai imminente fiera funeraria britannica e, vicini al nostro stand, Carmen Olmeda e Josè Manuel Martin de “La Guia Funeraria” accompagnati dal figlio. Assenti purtroppo, per impedimenti dell’ultimo minuto, Ildefonso Gonzales e Gabriela Esquivel della fiera messicana che nel 2011 si terrà nella bella e storica Puebla il 7 e l’8 marzo. Abbiamo ricevuto la visita di Jorge Bonacorsi, presidente della Fadedsfya argentina, estremamente soddisfatto del salone funerario di Buenos Aires di settembre, e quella dei brasiliani Iracema Nobre, presidentessa dell’associazione professionale dello stato di Cearà, e Garcez, Nieto e Giovàni, molto coinvolti col padre Filho e con Dario Loinaz, nel portare avanti il progetto d’avanguardia della Atlânticos Garden di Fortaleza in seno al quale un ruolo importante dovrebbe venir ricoperto dall’azienda Benedetti grazie al suo “ProgettoArgeo”. E poi, in giro per la fiera, abbiamo ritrovato Joe Bartolacci, numero uno della Matthews, e, presso lo stand di Hepburn Superior - US Chemical, Carlos Colòn, di cui abbiamo recentemente tessuto le lodi come scrittore, e Vince Monterosa.
Una importante delegazione filippina ha visitato la NFDA e, come sempre, molti i visitatori giunti dai paesi d’America latina. Una esposizione, insomma, che ha premiato la tenacità di Debbie Andres e una affluenza in aumento rispetto alle ultime edizioni (che la crisi incominci ad allontanarsi?) con una prima giornata molto frequentata che ci aveva lasciato sperare in un finale pirotecnico che però non c’è stato. Quest’anno anche il ricevimento riservato ad espositori e visitatori internazionali è stato eccellente così come una suggestiva cerimonia organizzata il secondo giorno, prima dell’apertura della fiera, nelle strade attigue al centro congressi. Si trattava di onorare i defunti di Katrina mettendo in scena un funerale tradizionale con tanto di carrozze tirate da cavalli ed orchestrina “Dixie” (il nome “dixie” viene dal fatto che nell’Ottocento sulle banconote da dieci dollari figurava non solo il numero in inglese - ten - ma anche quello in francese - dix -) conclusasi con la commovente, lunga e struggente proiezione su di uno schermo dei nomi di tutte le vittime del ciclone. Chissà che tra gli spettatori non ci fossero anche quei due impiegati di una impresa di pompe funebri locale che, presi in trappola in azienda dal rapido montare delle acque e non avendo nessuna via di scampo, decisero, con geniale e provvida iniziativa, di pigliare un “casket” (la bara dal formato americano tipico - le altre sono i “coffins”), di imbarcarsi (meglio sarebbe dire “imbararsi”) in esso e, sull’inconsueto ed originale naviglio, mettersi in salvo accogliendo, al passaggio, nell’improbabile battello un altro impiegato, del secondo piano, che tenendo tra le braccia il proprio gatto aveva trovato rifugio, in attesa di soccorsi, sul tetto della “funeral home”. Un segnale, un po’ comico, di vita in un mare di dolore e di desolazione.
New Orleans è ormai pronta a celebrare “Halloween” come testimoniano case e negozi già ornati di tutta la panoplia di circostanza. Gatti neri trasformati in “witches” (streghe) dal cappello arancione, scheletri pendenti da porte, finestre e balconi, pipistrelli, ragni e via di seguito. Non dubitiamo minimamente che la festa sarà grande, più che abbondantemente innaffiata ed all’altezza degli standard che volentieri riconosciamo agli incorreggibili “cajun”. Lì nessuno ha dimenticato che si vive una volta sola e che ogni occasione è buona per essere celebrata “comme il faut”. La parola d’ordine è: “Laisse le bon temps rouler”. In traduzione libera: “Approfitta del tempo presente”. Goodbye.