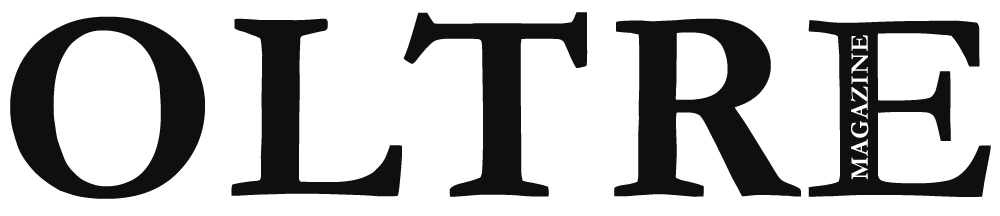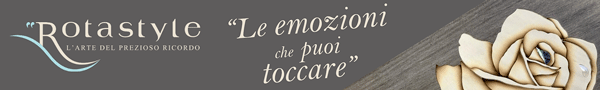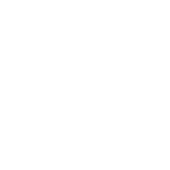Psicosi e spaesamento nei "terremotati" dell'Aquila
La morte davanti

Agosto 2009, tendopoli di Campo Globo e Piazza d’Armi all’Aquila: i “terremotati” (come si suole identificare e chiamare coloro che sono scampati alla tragedia, accomunati dall’averla vissuta e dal dover condividere il dramma del dopo-sisma) si raccontano e raccontano la loro esperienza di scampata morte o, meglio, di sopravvivenza. Sara, una ragazza aquilana di ventiquattro anni che, nella notte del 6 aprile 2009, ha vissuto la terribile scossa che ha ucciso centinaia di persone, morte sotto le macerie di case e di edifici distrutti, ripensava ai corpi ormai cadaveri, ritrovati sotto le macerie. “Quello della tenda davanti alla mia, lui l’ha visto. È uscito per andare al bagno e ha visto la luce blu che lampeggiava, la portavano sulla barella. Aveva gli occhi aperti e rivoltati all’indietro e la bocca spalancata. Era bianca come un cencio! Mi ha detto pure che quando l’hanno caricata aveva solo le mutande e la canottiera”. Nella tendopoli vivono le testimonianze e i ricordi delle vittime del terremoto per le quali la morte è sempre dinnanzi, vissuta ora come un trauma psicofisico incarnato nel corpo soprattutto di chi ha perso quella notte i propri cari, ora come inquietudine di una tragedia che può accadere di nuovo. Vi è, tuttavia, una dimensione contemporanea al terremoto e una posteriore, in cui avviene una sorta di “reinvenzione” e di “ripensamento” della morte stessa.
Durante i giorni del sisma e nei mesi immediatamente successivi, i “terremotati” hanno occupato le tendopoli allestite in diverse zone dell’Aquila e gli hotel della costa abruzzese trascorrendo i pomeriggi a ricordare, anche con l’ausilio di fotografie, i momenti vissuti nelle proprie abitazioni. “Tutta integra, dove sui muri c’erano i quadri che adesso sono in frantumi per terra e davanti alla porta il tappeto che avevamo preso in Marocco qualche anno prima”. La morte veniva scongiurata perché si era scampati a essa, mentre le pareti della propria casa crollavano e si cercavano vie di fuga. Maria, signora di trentasei anni residente a Campo Globo, descriveva la morte come “la nera signora” che, in quella notte, aveva avvolto il capoluogo abruzzese sterminando edifici e palazzi di cui sono rimasti cenere e polvere: “Era come una fotografia della seconda guerra mondiale … ti giravi e tutto era raso al suolo; chi gridava a destra, chi correva a sinistra, cercando e chiamando disperatamente il nome dei propri cari. La morte ti apparteneva, anche se non eri morto: vedevi cadaveri a terra, davanti alle porte, sotto le travi ... Chi riuscivi a vedere, perché poi tanti erano ancora sotto”.
Il trauma della morte faceva parte ormai della quotidianità di coloro che avevano vissuto, visto e toccato il terremoto: una compagna presente nei pensieri e una ferita incarnata nelle ossa che non veniva più tabuizzata, ma continuamente ricordata perché temuta. Simona, una delle sopravvissute, racconta quei momenti in modo quasi disincantato, oggettivando la paura che l’ha accompagnata mentre tutto intorno crollava e la stupefacente gioia di trovarsi ancora viva: “La terra ringhia, il rumore è assordante; ci alziamo. […] Le gambe vanno a vuoto, allargo le mani e ho l’impressione che le pareti laterali si chiudano, mentre quella di fronte mi viene addosso. Non è una impressione. Mi cade addosso di tutto. […] Sento le ossa del bacino scricchiolare sotto il cemento, mentre la trave in testa non mi impedisce di respirare. […] Ogni tanto sento le loro voci agitate e non capisco, sono lì, calma, buona, in silenzio… Sono svenuta più volte e loro non sapevano se ero viva o no. […] Nel mio folle ottimismo non ho mai pensato che avremmo potuto morire”.
Il dramma della perdita della casa, dei propri oggetti e dei propri beni, degli spazi familiari e della identità legata a una città sepolta dalle macerie era nulla rispetto alla constatazione di aver visto un padre o un fratello morire nello stesso tempo in cui altri si erano salvati. Psicologi di campo, assistenti sociali e psichiatri hanno seguito e ascoltato i racconti dei “terremotati” notando quanto fosse grande, spesso, il desiderio di parlare del trauma subìto e non ancora elaborato, nel tentativo di oggettivare le perdite (materiali e affettive) e di ricercare strategie di superamento del dramma incorporato. A questo proposito, la storia di Franca, ragazza trentaduenne incontrata a Campo Globo, è emblematica: “Sono rimasta sola con mia madre anziana, estratta dalle macerie dopo più di nove ore di agonia; noi siamo state estratte, ma ho visto il corpo di mio padre che chiedeva aiuto e io ero impotente mentre mio fratello era già morto. Lui urlava e mi diceva di sbloccarlo, ma io non riuscivo perché c’erano troppe travi; poi tutte pietre con una polvere che si è alzata dappertutto tanto che non riuscivo più a vedere. Sì, cercavo la porta, l’uscita, per chiedere aiuto per loro, per mia madre pure, ma non era possibile; tutto bloccato,… poi quelle grida, la mia schiena già a pezzi, le ossa che scricchiolavano, si attaccavano una sull’altra, ma io non sentivo quasi dolore; le gambe, facevo difficoltà a muoverle, cercavo, ma poi … insomma tutto buio, con un cadavere accanto che rifiutavo di guardare perché era mio fratello; con le grida a cui non sapevo dare risposta. Ho visto la morte dei miei cari in faccia e io mi trovavo a vivere. Ora ho il corpo frantumato in diversi punti, ma non è niente se ripenso a quei corpi improvvisamente immobili, bloccati”. Franca raccontava quasi con naturalezza la sua vicenda anche ai volontari che hanno prestato servizio nelle tendopoli dalla notte del 7 aprile al giorno del loro smantellamento. Una morte oggettivata, fin troppo interiorizzata nella mente e nel corpo di chi, con le mura domestiche e gli oggetti personali, aveva perso la vita dei propri congiunti.
Altrettanto significativa è l’esperienza di Valentina Nanni, medico specializzando in neuropsichiatria che, all’alba del 6 aprile, era accorsa d’urgenza per estrarre un ragazzo da quello che credeva fosse un buco, ma che in realtà corrispondeva al sottotetto di una casa dove lui si era ritrovato mentre dormiva al primo piano: “Vedo le gambe del ragazzo, livide e coperte da una polvere bianca, che spuntano sotto un pilastro di cemento grande, troppo grande. Sotto di lui c’è la rete del suo letto, incastrata nelle macerie. Mi dicono che devo parlargli, che devo tenerlo sveglio. […] Vedo il volto, una spalla e il braccio sinistro. […] Io continuo a chiamare quel ragazzo, lui c’è, mi risponde. […] Grido che bisogna sbrigarsi, ma le parole mi si strozzano in gola. Tutti sono lì per aiutare quel ragazzo, ma con le sole mani è tutto talmente lento! […] Lo chiamo e lo richiamo e quando chiude gli occhi il mio respiro si blocca finché non li riapre. Mi chiama, dice “Oh tu!”. Vuole sapere se hanno trovato i suoi piedi. Gli rispondo che i suoi piedi sono lì e che è normale che non li senta, ma sono lì, glielo assicuro. […] È un ragazzo giovanissimo e bello come il sole. Mi dice che ha dolore alla vescica. Ho paura di una lesione interna, di tante lesioni interne, ma se prova dolore alla vescica la schiena non è spezzata. Lui comincia a vomitare sangue, però è ancora vigile e ci risponde. Penso a quanto è forte e a quanto devo sperare che ce la faccia. […] non posso sapere come andrà a finire”. Corpi disintegrati, incastrati, in frantumi, in bilico tra la vita e la morte, che cercavano vie di fuga, pur resi infermi e invalidi dalle macerie. In questo senso la morte ha generato forti sensi di colpa e di autodistruzione inconsapevole per cui i sopravvissuti, soprattutto se in condizioni estreme (rinvenuti dopo molto tempo fra le macerie, feriti gravi o comatosi…), si domandavano continuamente la ragione per cui fossero stati risparmiati mentre altri erano stati condannati a non esserci più.

Nella mente e nei racconti dei “terremotati” l’idea della morte, intesa come un naturale e biologico rito di passaggio secondo quanto descritto da Van Gennep, è completamente sovvertita: non c’è il tempo dell’elaborazione della perdita e della preparazione della cerimonia funebre; completamente assenti sono l’intimità del defunto con il proprio nucleo familiare e l’esecuzione dei tradizionali riti che accompagnano la preparazione del cadavere e le sue esequie. Ogni vittima (che non è quindi terremotata perché non sopravvissuta) è diventata parte della città in lutto: duecentocinque dei duecentottantanove corpi trovati sotto le macerie sono tuttora conservati in bare tutte uguali che, nel giorno del venerdì santo, hanno gremito il piazzale della caserma della Guardia di Finanza a Coppito. Bare tutte uguali, allineate su quattro file, bianche quelle dei bambini sulle quali un giocattolo, una scritta di identificazione, un fiore o la t-shirt della squadra del cuore sono state poste rompendo l’anonimato che sembrava dominare sulle altre. “Ho l’impressione che molti prendano tutto ciò per i funerali della città. Chiunque ha da piangere. Chiunque ha perso qualcosa. […] Bare piccole, bare grandi. Parenti delle vittime. E forse anche qualche carnefice. Chissà. […] Ognuno ha portato con sé la propria storia. Centinaia di storie riunite in un piazzale. Tante storie le conoscevo, tante me le hanno raccontate, tante altre ancora non le saprò mai. […] Non sappiamo il numero della bara di Pass’ammè, ma non m’importa. Ogni bara è Pasquale Alti, detto Pass’ammè. Ogni bara è un neonato, e un vecchio, e uno studente. Ogni bara è un nostro caro caduto. Ogni bara siamo noi, che stiamo qui, in piedi, solo perché più fortunati. Ma al loro posto saremmo potuti essere noi. E bara è questo piazzale, questi edifici. Bara, in fondo, è la nostra città”.
Funerali di Stato, di fronte ai parenti sopravvissuti e agli italiani che, pur lontani dall’Aquila, seguivano il momento triste dell’ossequio funebre: “Questo certamente ci ha fatto piacere, cioè l’Aquila non è mai stata tanto conosciuta né nominata come in quei giorni, anzi… non si parlava d’altro! Tutti che ci volevano aiutare, tutti che spedivano soldi e roba che poi è andata anche sprecata. Alla fine però noi abbiamo perso le nostre cose, noi abbiamo visto la morte in faccia o persino abbiamo seppellito i nostri cari”, diceva Lucio, giovane studente aquilano che è rimasto sei mesi nella tendopoli di Piazza d’Armi. Come altri suoi concittadini e compagni di tenda lamentava l’indiscreta incursione dei mass media, diventati (come spesso avviene in simili occasioni) il filo conduttore di quella rara umanità per cui ogni abitante d’Italia si identificava nella tragedia e nelle sue vittime, “come se a morire fosse ciascuno di loro. Questo ci ha fatto piacere, ci ha aiutati, ma la morte era nostra, dei nostri cari, della nostra città”.
Il morto era diventato oggettivazione del dramma collettivo, unione del Paese (e non solo dell’Aquila o della sua regione) di fronte alla futilità della vita umana che veniva rappresentata dai circa trecento nomi che scorrevano, ininterrottamente, come epilogo dei telegiornali o dei documentari di quei giorni in cui, alla televisione, sul web e alla radio non si parlava d’altro. E la morte univa, livellava, come direbbe Totò, anche chi passava inosservato, anche chi non apparteneva alla nostra comunità, anzi, ne veniva spesso escluso. Infatti è stato dato risalto anche alle esequie rese ai defunti di religione musulmana per i quali è stato celebrato il rito del commiato dall’imam Mohammed Nour, che ha evocato la pace e l’unione su tutti i popoli in nome di un solo Dio. Loro, seppur nella diversità, erano vittime del terremoto, ancora più anonimi degli altri feretri, perché emigrati e soggetti a uno spaesamento identitario e affettivo.
Identificazione della nazione con il dolore e con la morte, non più individuale ma comunitaria, collettiva, ben più di quanto Hertz descrisse agli inizi del Novecento, sottolineando la gradualità sociale dell’atto del morire, la separazione del defunto dal mondo dei vivi e l’entrata in quello dei morti. Non scompaiono soltanto l’individuo biologico e la sua identità sociale, ma una intera comunità che vede nei feretri esposti la forza della fatalità e la potenza della natura, contro cui l’uomo, inerte, e la società stessa si sentono completamente impotenti. Ancora Lucio: “Guardi quelle bare e capisci che tu sei lì per sbaglio, perché magari non ti è caduta la trave addosso, perché sei riuscito a uscire in un attimo di secondo prima che il tetto disintegrasse tutto. Sentivo muovere in senso rotatorio, sussultorio e ondulatorio tutto; cercavo, gridavo il nome delle mie bambine e non le vedevo… guardi queste bare e dici che sei qui per caso, perché a loro e non a te, perché la natura ha sconvolto un ordine che in realtà non c’era, perché nulla ha senso, perché decide e opera come vuole”.
La natura matrigna, di chiara eco leopardiana, ritornava nei racconti dei terremotati adulti che, soprattutto giorni e settimane dopo il 6 aprile, vivevano in una quotidiana psicosi della morte e della catastrofe, rifiutando di dormire in luoghi chiusi ben circoscritti da pareti o porte. Lucio ripeteva spesso, all’avvertimento repentino anche di una minima scossa di assestamento, quando tutti si riversavano lanciandosi per le strade o sui tracciati delle tendopoli: “Tutti piangono e guardano nel vuoto, hanno, abbiamo paura, terrore che possa accadere di nuovo. Ecco perché non vogliamo andare a dormire dentro una casa con le pareti che stringono e opprimono. C’è la paura che ci crolli tutto addosso, mentre qui andiamo fuori dalla tenda e siamo liberi, sicuri che al massimo ci può crollare la tenda che tanto non ci appartiene. La cosa invece più strana è quello che fanno i bambini! Oggi pomeriggio, per esempio, ho visto alcuni che simulavano la scossa muovendo la tenda mentre gli altri si nascondevano all’interno e poi correvano fuori urlando: la scossa, la scossa, uscite!”. I bambini, terremotati anche loro ma padroni della libertà di muoversi e di giocare nelle tendopoli quasi come in un campeggio, sdrammatizzavano la morte e l’evento stesso al punto da aver inventato il gioco “terremoto”. Roberto, bimbo di sei anni la cui famiglia condivideva la tenda con un’altra con due figlie sue coetanee, così spiegava mentre correva per i vicoli di Campo Globo, rifiutando di restare nella “casa-tenda”, come lui la chiamava: “Sì, noi giochiamo al terremoto, come quella sera è successo, cioè quella notte, quando, per esempio casa mia si è schiacciata come una merendina, mentre intorno girava tutto, come una giostra e io chiamavo la mamma perché si è spenta anche la luce. E poi, intorno, nient’altro, il vuoto, anzi ho visto pure il mio vicino di casa che stava a terra e non si muoveva più; non lo so, ho chiesto se dormiva, ma non mi rispondeva e non si muoveva neppure. Il giorno prima era venuto con me a passeggio con il mio cane, mentre poi non si muoveva più”.
I bambini giocavano con la morte, tabuizzandola, gli adulti, i “terremotati”, imparavano a convivere con il trauma e con il fantasma di essa, allontanandola nella pratica quotidiana della ricerca della normalità. La morte veniva, in tal senso, persino commercializzata, pubblicizzata ed enfatizzata perché il lettore o l’ascoltatore massmediatico potesse meglio identificarsi, piangendo, con chi vedeva disperare dinnanzi alla bara del proprio defunto: le telecamere, infatti, inquadravano la madre che, straziata, abbracciava il feretro bianco o la donna che chiamava, invano, il nome del marito inciso su un legno ricoperto di fiori; lo zoom descriveva una famiglia che condivideva il risicato spazio di una tenda, sacrificando la propria intimità familiare e coniugale per mesi. Lo stesso Roberto ha affermato: “Siamo sulla bocca di tutti, perché tutti dicono l’Aquila qua e l’Aquila là; allora io mi diverto quando vedo le telecamere perché saluto i nonni che, invece, stanno a Pescara. Poi però, come dice mamma, mi danno fastidio quando ti chiamano, ti chiedono anche certe cose strane, per esempio come dormi, com’è il letto rispetto a quello che c’era a casa tua, se vai in bagno con la mamma oppure da solo, se ti mancano i tuoi giochi. Certe volte vogliono persino sapere come ho visto il mio vicino morto … oppure dove sono fuggito quando non vedevo niente ma solo tutto nero con la polvere; uffa, mi sembrano strane queste domande!”.

La tendopoli di Campo Globo era abitata anche dai malati del Centro di igiene mentale che occupavano un intero settore, sorvegliati e accuditi da psicologi e infermieri. Il loro sguardo spaesato, ma inconsapevolmente sereno, le parole sommessamente pronunciate alla richiesta di raccontare come avessero vissuto gli attimi del terremoto, denotano un approccio ancora differente rispetto alla morte. Rita, una ragazza trentenne che condivideva con donne più anziane del Centro una casa-famiglia a Collemaggio, scrivendo sui diari che quotidianamente aggiornava fuori dalla tenda da dove salutava tutti “gli abitanti” del campo, raccontava quasi in una forma di soliloquio condiviso con i volontari con cui si intratteneva a parlare per interi pomeriggi: “Io mi sento libera qui, conosco tante persone, non ho paura del terremoto come ce l’avevo dentro quella casa. Qui esco, chiamo, trovo sempre qualcuno, mentre là ci sono solo loro [indicando le altre malate del Centro] che … insomma, non siamo normali, ma lì non avevamo comunque niente e nessuno, se non queste valigie che ora stanno nella tenda. Un letto vale l’altro, un comodino o una sedia sono la stessa cosa, ma almeno qui ti senti come tutti, anche se nella difficoltà … e quasi hai meno paura che può risuccedere, meno paura di vedere ancora corpi che non si muovono più”. In questo caso, paradossalmente, la morte scampata era quella delle pareti della malattia e della costrizione quotidiana alla ripetizione degli stessi gesti con le stesse persone e negli stessi tempi.
La tendopoli rappresentava per gran parte di loro l’occasione per sentirsi normali (almeno accomunati agli altri, perché “terremotati”), per uscire dalle mura della quotidianità e per stare con e tra la gente, seguendone e riproducendone le abitudini. Rita proseguiva: “Ti senti parte di questa comunità perché, pure se devi prendere i farmaci, fai le cose che fanno tutti gli altri; mangi con loro alla mensa dell’Esercito o della Marina (a me piace più quella dell’Esercito anche perché i ragazzi sono più belli!), assisti all’alzabandiera, vai a farti la doccia dove ci sono le altre donne del campo, vai a chiedere lo shampoo o il sapone allo spaccio dove stanno gli alpini che sono tanto gentili con tutti! Insomma, ti senti normale, anche se sai di non esserlo fino in fondo”. La sopravvivenza al terremoto e la distruzione del luogo di “internamento” sembra quasi aver favorito una sorta di liberazione non solo mentale, ma anche fisica, tanto da edulcorare persino la percezione del dramma stesso, come Rita più volte ha affermato: “In quei momenti abbiamo visto la morte in faccia, non sapevamo chi chiamare, cadeva tutto… ma forse è stata una scossa anche nella nostra vita, per provare altre cose… Oddio, per fortuna che siamo vive e per fortuna che siamo qui alla tendopoli e non più in quelle case dove però, purtroppo, so che ritorneremo”. La morte dei “malati di mente”, come talora i mass media hanno apostrofato, era quella scongiurata durante la notte del sisma, scalfita nel corpo come terrore ma, in parte e più velocemente “dei sani”, rielaborata perché più basso è il valore della perdita materiale e affettiva proprio per chi non ha una sua casa, una sua famiglia e un suo spazio quotidiano.
Morti, tuttavia, non erano soltanto i corpi e le persone, ma morta era la città sulle cui strade, soprattutto nel centro, si leggevano cartelli affissi sulle vetrine infrante dei negozi: “Chiuso dal 6 aprile 2009 … Si riapre il …?”. Il centro storico non esisteva più, il silenzio dominava le strade accessibili soltanto alle forze dell’ordine e il silenzio penetrava nelle case abbandonate dove si intravedono ancora i vestiti stesi ad asciugare oppure le finestre semi aperte che avevano assistito e, tante volte, permesso i tentativi di fuga. La città è morta e con essa l’identità dei suoi abitanti che ora, a distanza di più di un anno, inseguono la speranza della ricostruzione mentre le istituzioni e i magistrati vanno a caccia di chi abbia compiuto errori edilizi, di chi non ha preavvertito la “grande scossa”, di chi avrebbe potuto meglio gestire la “macchina terremoto”. Dov’è la morte nel “post-post terremoto”, nella fase cosiddetta della ricostruzione, quando i morti sono stati sepolti e i vivi, i “terremotati” appunto, cercano di riappropriarsi di una normale (verosimile) quotidianità?
Con il tempo e con il passare dei giorni è morta anche la notizia del terremoto, che gremiva e occupava le reti televisive e radiofoniche dei giorni successivi a quello del disastro, come è morta l’urgenza di occuparsi della psicosi del crollo, del movimento e delle macerie, che accompagna i vivi, pur in una parvenza di normalità. Lucio afferma ora: “Sì, ci sforziamo di riprendere le cose normali, quasi facendo finta che non sia successo niente oppure senza pensarci, ma non è la stessa cosa! Ti senti trascinato dal ricordo, cioè oppresso dal trauma che porti dentro, soprattutto per chi ha perso qualcuno. Poi non hai più i punti di riferimento; l’Aquila è distrutta, il centro non c’è più e ricordi quando ci passeggiavi incontrando gli amici o fermandoti a prendere un caffè sotto i portici. Questo non esiste più, come se ci avessero portato via una parte di noi”. Si assiste oggi a una de-territorializzazione dell’idea di morte, causata dalla perdita dei punti di riferimento che costruivano, dapprima, la quotidianità individuale e familiare, dalla consapevolezza di uno spaesamento dovuto alla perdita della casa, degli oggetti, degli spazi domestici e del loro impiego, poiché il soggetto non riesce più a ricollocarsi in una realtà del tutto cambiata, che non gli appartiene. “Ci possono dare tutte le case che vogliono, ma non hai più la tua e soprattutto non hai più quella capacità di gestione e di movimento che avevi nei luoghi che erano tuoi!”, dice Lucio, con lo stesso rammarico e forse inconsapevole dispiacere del piccolo Roberto: “Non ho più i miei giochi, la cameretta, il cortile dove invitavo gli amici. Ora questa casa è pure bella, cioè non è la tenda, ma non è la mia, quella dove avevo tutto”.
Nel “post-post terremoto” si avverte calzante la psicosi della morte, non tanto come spauracchio incombente sull’immaginario del terremotato (forse perché scampata, una prima volta, e rielaborata, una seconda volta, con quei funerali di Stato?) quanto come consapevole perdita della propria identità, legata al rapporto con il territorio (tuttora fantasma, in lenta ricostruzione) e con quei canoni sociali e culturali che contrassegnano l’individuo vivo nella collettività. Il terremoto del 6 aprile 2009 ha generato tante morti, ma con essi circa diecimila vivi che oggi convivono nel ricordo di esse in un quotidiano, seppur mascherato e talora luttuoso, spaesamento.